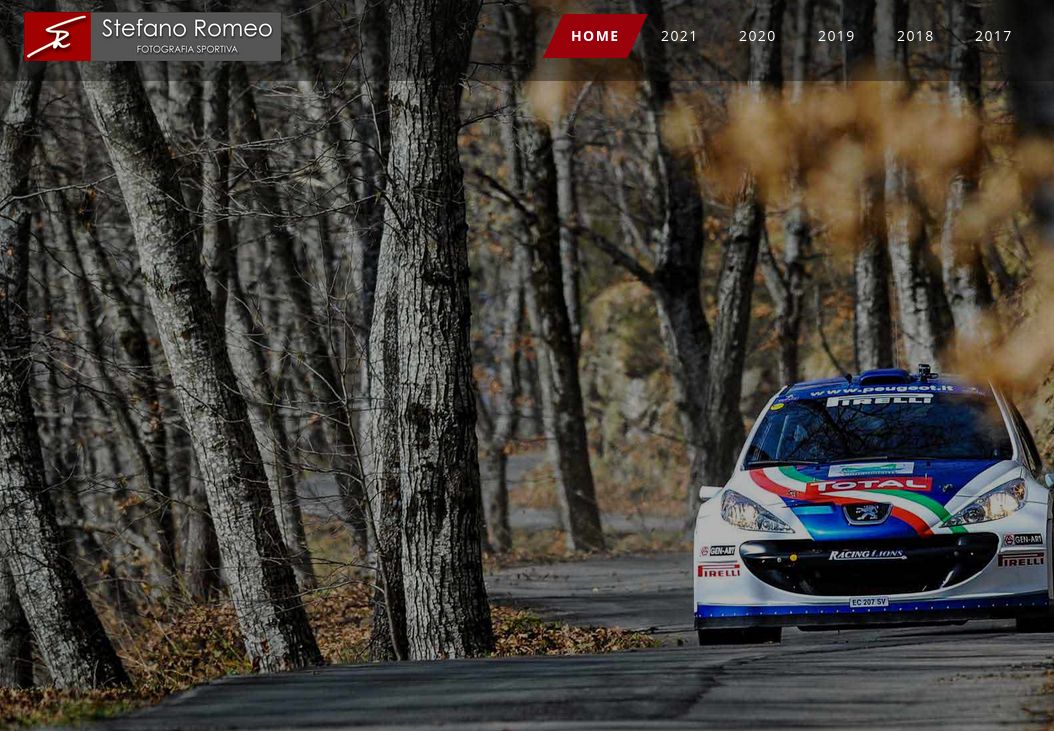In anticipo di cinque secoli la Milano di Ludovico il Moro cambia. Durante il suo governo la città conosce il pieno Rinascimento. La sua corte diventa una delle più splendide d’Europa. Patrono di molti artisti di rilievo tra cui Leonardo da Vinci, il Moro è noto per avergli commissionato l’Ultima Cena, e lo è altrettanto nelle vesti di donnaiolo, soprattutto quando per lui suona finalmente l’ora dell’usurpatore dalla pelle bruna. Ludovico toglie il potere al nipote Gian Galeazzo, figlio di Galeazzo Maria, e più che mai pretende il ducato di Milano. La sua corte diventa felicemente famosa, o tristemente, secondo i punti di vista, per la licenziosità dei costumi. Il nuovo duca non è privo di una educazione classica, nonostante il suo carattere stravagante, sa attrarre sempre più artisti di alto livello. Il più grande, Leonardo, deluso da Lorenzo il Magnifico, abbandona Firenze per Milano dove, oltre all’arte pittorica eccelsa, porta doti ingegneristiche e progetta bombarde. Peccato che il Moro non valuti in modo adeguato l’inventiva bellica del Vinci, ricca di tecnologie avanzate. Il duca generalmente non usa l’artiglieria, nel momento del pericolo. In compenso può recarsi a pregare la Vergine delle Rocce. Ludovico Maria Sforza, ha trentasei anni, quando conosce Cecilia sedicenne.
Discordi sono i pareri sulla personalità del duca. Chi lo descrive di buona, chi di mala natura. Di certo è un
dissimulatore disonesto. Ascolta, non si lascia trascinare dalla collera, fa finta di niente e, al
momento più opportuno, si vendica. Gli Sforza, dopo la morte dell’ultimo Visconti, conquistano
la Repubblica Ambrosiana, salvandola dalla catastrofe economica dovuta all’incapacità dei
repubblicani. Subentra Galeazzo Maria Sforza, grande e prodigo mecenate che richiama
umanisti, artisti e studiosi. Instaura però una tirannia crudele e, dieci anni dopo, il giorno di Santo
Stefano, il 26 dicembre 1476, alla messa solenne nella chiesa omonima dietro l’Arcivescovado,
il duca si presenta senza la corazza. Non è riuscito ad indossarla perché in sovrappeso, più di
quanto sia considerato normale o salutare. E’ vero che l’obesità, a quei tempi, è un segno di
prosperità e benessere, in quanto suppone denaro sufficiente per mangiare tutto il cibo che si
vuole, a dispetto di chi muore di fame. Gli affamati sono tanti quanto i grassi anche allora. Va
da se che tre giovanotti milanesi, repubblicani e antitirannici, considerano la grassezza del duca
più di un insulto, quindi un altro buon motivo per agire. Stranamente le chiese sono un luogo
prediletto per efferati delitti, come avverrà due anni più tardi anche a Firenze, in Santa Maria
Novella, con la congiura dei Pazzi. Il duca procede a fatica tra la folla che lo acclama, difeso solo
dal suo adipe e da uno splendido abbigliamento, ma non dall’acciaio. Antesignana del giubbotto
antiproiettile, la corazza è rimasta al Castello. Nel mezzo della calca, non ancora entrato nella
chiesa, viene assassinato a pugnalate sulla scalinata dai tre congiurati. Due vengono linciati,
seduta stante, il terzo scappa. Si rifugia in casa del padre. Il genitore, tutt’altro che protettivo, lo
denuncia. Verrà giustiziato.
La successione si complica fin dall’inizio. Nell’album delle figurine dell’epoca, se mai ci
fossero state, i fratelli del Duca sarebbero considerati assai poco. Vengono esiliati. Prende il
comando Bona di Savoia, vedova di Galeazzo Maria morto senza corazza, senza confessione,
senza pentimento. E sì che di peccati ne aveva tanti! Vizi carnali, simonie, ingiustizie, imposte a
destra e a manca, senza contare saccheggi, ruberie ed estorsioni. Bona dimostra molta forza di
carattere, soprattutto nel difendere il primogenito Gian Galeazzo Maria, di nove anni. Contrastata
dai cognati, con l’aiuto di Cicco Simonetta suo segretario, è lei che riesce a farli esiliare. Ma il
Moro non si fa attendere, allestisce un esercito e invade il Ducato, favorito anche dalla caduta in
disgrazia del Simonetta. Bona che ha una relazione con Antonio Tassino, nemico acerrimo del
segretario ducale, si riconcilia con il cognato, e condanna il Simonetta alla pena capitale. Prima
di salire al patibolo, a Pavia, il Simonetta pronuncia la famosa frase: “Eccellenza illustrissima a
me sarà tagliato il capo ma voi, in processo di tempo, perderete lo stato.”Parole più che veritiere!
Anche se Bona rimane ufficialmente ancora la reggente, il Moro, con
il pretesto di proteggere la vita del nipote dal Tassino, non ci pensa due volte e fa rinchiudere
Gian Galeazzo nella Rocchetta, l’area più sicura del Castello Sforzesco. La morte del Simonetta
toglie di mezzo il principale avversario del Tassino che diventa sempre più arrogante. Se il Moro
o altri nobili vanno a fargli visita, li fa attendere a lungo fuori dalla porta, finché non finisce di
pettinarsi. La duchessa succube del suo amante, va su tutte le furie quando il Tassino, fatto
arrestare dal Moro, viene esiliato a Venezia in cambio di una grossa somma di ducati. Poco
dopo, Gian Galeazzo firma un documento che nomina il Moro suo tutore. Bona di Savoia tenta
allora di far avvelenare il Moro senza però riuscirci. Una seconda congiura, progettata sempre
dalla duchessa, fallisce anche questa. Bona cerca di fuggire in Francia, e il Moro la costringe ad
una prigionia dorata nel Castello di Abbiategrasso, con una pensione di 25000 ducati, evitandole
il processo. Un lungo corteo si avvia alla nuova sede. E’ inutile dire che gran parte del seguito è
formato dalle spie del Moro.
Nel settembre del 1480 Ludovico avvia una trattativa con Ercole d’Este per ottenere la mano
della primogenita Isabella. Il fidanzamento non è possibile. Il padre pochi mesi prima l’ha
promessa, all’età di soli cinque anni, a Francesco Gonzaga, marchese di Mantova. Al Moro viene
dunque proposta la secondogenita Beatrice. Il duca non esita ad accettare.
A questo punto della cronistoria, il Bergamino si siede al suo tavolo fratino, prende la
penna d’oca, l’intinge nell’inchiostro, e scrive un dialogo immaginario tra Bona e suo figlio. Nel
Rinascimento l’esigenza di un’espansione del servizio postale è molto sentita dalla nobiltà e dalla
borghesia. I nuovi commerci hanno sempre più la necessità di informazioni e comunicazioni
con i luoghi lontani. La distanza pur breve tra Milano e Abbiategrasso, non permette tuttavia di
servirsi dei corrieri a cavallo. Troppo frequenti sono le rapine. Dotato di una fantasia invidiabile,
escluso che Bona possa recarsi col permesso del Moro a Milano o, viceversa, Gian Galeazzo
fare una scappatella ad Abbiategrasso, li fa parlare come se si fossero per caso incontrati.
Non è al corrente che per il giovane Gian Galeazzo, la vita è cambiata radicalmente. Sotto la
reggenza della madre e del Simonetta conduceva un'esistenza sì agiata ma improntata anche
ad una discreta educazione politica, ora invece, rinchiuso dallo zio, vive in un giardino di delizie
che ha lo scopo di rammollire il suo animo, onde evitare il sorgere in lui di qualsiasi desiderio
di rivalsa. Non è più rinchiuso nella Rocchetta, ma nel Castello di Pavia. Passa le giornate
divertendosi: caccia, donne, giovinetti, profumi, begli abiti, ama al modo dei tempi suoi, e nulla gli
si addice meglio del giardino di delizie che lo zio gli ha apprestato tra Castello e parco a Pavia.
Il Bergamino non conosce, occupato com’è a scrivere, tutte le manovre politiche del Moro, né
gli interessano più di tanto, ha un altro problema che gli frulla nel cervello, pertanto immagina e
scrive questo dialogo.
“Hai visto che cosa abbiamo combinato?...”
“Madre, sì, però, credo di averti già detto qualcosa in proposito.”
“Arrivati al punto in cui ci troviamo, direi che anche le più fosche previsioni siano superate!”
“Non ti ho sempre ripetuto che dallo zio c’è da aspettarsi di tutto?”
“Mi spieghi allora perché hai firmato quel documento che gli assegna ogni potere su di te?”
“Mi ci ha costretto, minacciandomi di farmi incatenare”
“Sì, a parole! Non ti vergogni?”
“No, sei tu che ti devi vergognare, di esserti innamorata di un tuo dipendente, di aver dato il
via a ben due tentativi di avvelenamento, usando, anziché una sostanza tossica, un prototipo di
ricostituente, una serie unica, da tenere in conto se dovessi ammalarmi!”
“Vuoi ficcarti in mente che tuo zio è il più grande egocentrico che esista sulla faccia della
terra?... Poi, vengono fuori delle sozzerie di cui bisognerebbe soltanto inorridire!”“Ma lui dice che conosce bene la situazione...”
“Sì, anche a me l’ha detto, ma si vede che ignora le conseguenze che tutte le sue malefatte
producono nel ducato e pure fuori!”
“Si arrangi, è affare suo...”
“Non ci resta che tirare a campare!”
“Forse è la cosa migliore!”
“Tutto sommato una virtù ce l’ha. Non è avaro.”
“Tu dici madre? Perché ti ha donato 25000 ducati? Vedessi come mi fa vivere alla Rocchetta,
peggio che in una prigione, costretto a dormire su di un piano di legno, senza il materasso,
avaraccio!”
“Ricordati che gli avari non esistono, ci sono solo per quelli che non distinguono tra risparmio
e spreco!”
“Ah, secondo te Ludovico sarebbe per questo oculato, parco, cauto, previdente, equilibrato?
Metterebbe persino una tassa sull’aria che si respira... Certo, se lo guardi in viso, il doppio mento
gli dona una fisionomia bonaria, quasi da pacioccone, ma il grosso naso sembra il becco di un
rapace!”
A questo punto gli scambi verbali tra i due, il Bergamino li fa terminare. Non esiste un motivo
narrativo che dal particolare porti all’universale. Il Manzoni non è ancora nato, altrimenti non
faticherebbe a riconoscere i “Polli di Renzo”. Madre e figlio si beccano, ma alla fine, forse,
entrambi si accorgono del naso importante del Moro, aquilino, come quello di un uccello rapitore
vorace e ingordo.
Il conte Carminati di Brembilla, giunto al traguardo degli anni cinquanta, passa molto
tempo a scrivere. Il suo linguaggio narrativo è visionario, reinventa l’ossimoro, l’onnipresenza
dell’ossimoro. Per realizzare il suo modo di comunicare, mette in luce la parte più nascosta
dell’uomo, dell’effimera esistenza umana, il conscio. Precede di mezzo millennio uno tra i
massimi geni letterari del Novecento, l’argentino Jorge Borges Acevedo. Ma, a differenza
dello scrittore sudamericano, non ha bisogno di diventare cieco per poter utilizzare l’oscurità
in senso creativo. Il Bergamino, nella tranquillità del suo studio, deve soltanto chiudere gli
occhi. Il Rinascimento gli offre l’occasione di sfruttare la sua potenza schizofrenica in materia
letteraria. Utilizza la realtà come plagio, falso, menzogna e parodia universale, assaporando
la libertà di divertirsi in qualsiasi modo, senza preoccuparsi dei pensieri o dei giudizi altrui.
Dopo ogni invenzione letteraria, breve o lunga che sia, la sua vita nevrotica ad occhi aperti si
trasforma, il suo tormento della vita quotidiana scompare, l’agro diventa dolce e, a volte, gli
succede di scoprire un universo nuovo dove, come dice Corneille, l’oscura chiarità può anche
cadere dalle stelle. Pure Lodovico il Moro è talmente abituato a dire e ritrattare la stessa cosa,
a promettere e non mantenere, a sorridere e pensare alla vendetta da non doversene stupire e, a
volte, nemmeno da accorgersene. Il pensiero, nello stesso tempo galvanizzante e sedativo, lo fa
veramente star bene. Il Bergamino da tempo lo studia. D’altro canto gli stessi modi di governare
del duca, sono ancora più diffusi nei vari regni, stati, ducati, repubbliche in cui si divide l’Italia
rinascimentale, nonché nell’Europa. Un punto di vista per risolvere, quando si può, le opposizioni
binarie nella maniera più dozzinale, in una acquisizione cumulativa, è l’ossimoro, figura retorica
che in realtà significa intelligente-stupido. Sarebbe come affermare che odiare fa star bene,
perché più si odia e più ci si sente cattivi, ci si potrebbe scoprire anche buoni. Se scrive,il
Bergamino si sfoga, usa lo stesso metodo del duca quando copula, la serotonina gli aumenta
veloce nel sangue, la rabbia gli si trasforma in benessere, e più sovente ancora in una risata
intrattenibile.
Questa volta il Bergamino non straccia lo scritto, anzi, lo ripone sotto chiave in uno scomparto
ben nascosto della libreria. Si guarda di nuovo nello specchio e nota che la sua pancia sporge.
L’ultima volta che è riuscito ad infilarsi nella corazza, i suoi servi hanno faticato non poco per
fargliela indossare. La tristissima vicenda di Galeazzo Maria sulla scalinata della chiesa di SantoStefano gli frulla nella memoria.
A parte la sanguinaria fine del duca, presto ci sarà un torneo
al quale vorrebbe partecipare. Che l’abito non faccia il monaco, pensa, sarà anche vero, ma
l’armatura da giostra, una ostentazione senza eguali del potere e del lusso della corte, eccome
che lo fa. Esce, raggiunge a passi veloci il centro di Milano, un labirinto di viuzze che portano
i nomi dei tanti mestieri. Si ferma davanti a una bottega di via Spadari. Agli stipiti del grande
ingresso, fanno spicco due armature del XIII secolo, appese ad altezza d’uomo. Anche il nome
della via stessa si adegua alla forte concentrazione di botteghe di armaioli.
Il Bergamino, così chiamato perché nato da una delle più note famiglie della Val Brembilla
vicina a Bergamo, all’età di dodici anni, fa già parte dei paggi di Francesco Sforza. A venticinque
anni è camerario ducale e l’anno dopo è capitano dell’esercito sforzesco. I duchi di Milano,
investiti da Luigi XI del feudo di Genova, lo inviano contro i Campofregoso, che tenacemente
gli si oppongono. Per quella occasione ha addirittura il comando della bombarda ducale più
potente, la Corona. La sua carriera militare è rapidissima. Molto presto è fra i capi dell’esercito
della lega che Galeazzo Sforza, non ancora assassinato nella chiesa di Santo Stefano, guida con
gli alleati fiorentini e napoletani contro i veneziani guidati da Bartolomeo Colleoni. I rapporti con
questo duca rimangono anch’essi improntati a una confidenza diffidente, tanto per rimanere
negli ossimori. Cambiano quando Bona di Savoia, divenuta reggente in nome del figlio Gian
Galeazzo, si trova alle sue prime difficoltà. Il Bergamino, uno dei condottieri dell’esercito ducale,
non è fortunato, e gli sforzeschi sono sconfitti nella battaglia della Busalla che causa la perdita
di Genova. Fatto prigioniero insieme ad altri, verrà in seguito scambiato. Tornato libero, sarà
nuovamente sconfitto dai confederati svizzeri. Deciso a lasciare l’esercito, si convince che
cambiare l’armatura da combattimento con quella da giostra sia più conveniente, e quando il
Moro, diverrà reggente, lo creerà consigliere delle Stato di Milano.
Il Bergamino giunto alla bottega dell’armaiolo indugia a entrare, sta lì sulla soglia tra le due
armature appese. Riflette. Tutto sommato, la giostra, alla sua età, non è poi che gli interessi
più di tanto. II rischio di venire disarcionato da gagliardi avversari giovani ed aitanti, è più che
probabile. Un disarcionamento, col suo peso massiccio, potrebbe ridurlo molto a mal partito,
pur senza perdere la vista come Paolo di Tarso, né dover arrestare dei cristiani, né doversi
convertire perché già battezzato. Meglio per il momento accontentarsi, starsene al comando
dell’esercito e poter ordinare agli armigeri il corpo a corpo, seguendo da lontano lo svolgersi
della battaglia ben saldo in sella al proprio nobile destriero. Tanto più che, proprio in quel mese
di luglio 1492, mentre Cristoforo Colombo scopre il nuovo mondo, lui sta scovando le virtù di
una procace fanciulla di diciannove anni. Passati gli entusiasmi iniziali, prevedibili in un anziano
guerriero che ha scelto di combattere la depressione con la penna, sopportando i capricci
dell’amante di un duca predatore, Ludovico il Moro. Stregato al punto di richiedere a Leonardo
un ritratto di lei, il duca mai gliela avrebbe concessa in moglie se non avesse dovuto sposare
Beatrice d’Este e se Cecilia non gli avesse partorito un figlio, Cesare. Una situazione affettiva
delle più balorde quella toccata in sorte al povero Bergamino, obbligato a seminare un orticello
che non gli appartiene e a dimostrare così la rettitudine di ciò che fa, trasformando il negativo
in positivo, mutamento essenziale all’economia del suo prepotente signore. Peggio sarebbe
stato se gli avesse dato in custodia anche il ritratto, la Dama con l’ermellino, in cui gli occhi di
Cecilia sono rivolti a sinistra, come se guardassero qualcun’altro, forse il duca stesso appena
lasciato. Non manca a Cecilia in quel quadro un sorriso misterioso, forse d’intesa, anticipatore
di quell’altro più noto della Gioconda. Anche Leonardo non consegnerà mai il ritratto di Monna
Lisa al marito committente, Francesco del Giocondo, fornito mercante fiorentino, tant’è che non
porterà a compimento il dipinto. Gli rimarrà fino alla fine, nella sua ultima dimora ad Amboise
dove, con ogni probabilità, l’acquisterà il re Francesco I. Sembrerebbe pertanto che le intenzioni
del Moro e di Leonardo da Vinci abbiano una spiegazione univoca; quei due ritratti non devono
appartenere ai mariti, Cecilia al Bergamino, e Monna Lisa a Francesco del Giocondo. Realtà e
razionalità non sempre coincidono, le cose vanno, talvolta, diversamente da come le pensiamo.
Nessuno saprà mai come abbia reagito il Giocondo. Il Bergamino, con un’ironia sconfinante nel sarcasmo,
se avesse potuto, di certo gli avrebbe detto: “Ti ringrazio di cuore mio signore, ora
hai una moglie di alto lignaggio! Dell’amante puoi sempre guardarne il ritratto”, quando a tutti
era noto che sua moglie non poteva reggere il confronto con Cecilia. Beatrice d’Este, infatti, è di
bassa statura, tanto che indossa apposite pianelle per cercare di ridurre la differenza d’altezza
con il marito, il cui sviluppo verticale raggiunge il metro e novanta. E per di più è cicciottella, ha
il naso piccolo all’insù, le guancie paffutelle, le labbra sottili e i capelli avvolti in una unica treccia
alla catalana che raggiunge le natiche, come a voler far sapere: “Qualcosa di esteso anch’io ce
l’ho!”
Il piccolo animale che Cecilia tiene in braccio nel dipinto leonardesco, si riferisce pure al
Moro. E’ il re di Napoli che gli ha dato l’autorevole onorificenza dell’Ordine dell’Ermellino, per il
momento conferita solo al re d’Inghilterra e al duca di Urbino. Decorazione di potere ed anche
di purezza, una integrità quest’ultima inappropriata e inopportuna, se pensiamo che il duca ha
un’amante sedicenne. Il Bergamino, un po’ fuori fuoco in confronto, esce dal covile oscuro della
dimenticanza, per usare un’espressione del Manzoni. Sarebbe restato anche lui un anonimo, se
non avesse sposato la giovanissima amante del suo signore. Ad onta della sua manifesta libido,
sarebbe rimasto comunque un succube del Moro. Spingendolo a prendersi in moglie Cecilia,
fa quasi venire in mente il pasto che si concede al suppliziato per prepararlo al seguito. Dopo
gli sponsali sollecitati dal duca, il Bergamino al momento sorpreso e felice, col trascorrere del
tempo non lo è più. Forse stava meglio prima, quando usava la spada, anziché la penna e non gli
importava di essere un condottiero di molte battaglie perse, si accontentava. Ora è depresso,
si sente comico di fronte alla gente. Non può permettersi nemmeno di cadere da cavallo,
grosso com’è farebbe ridere ancora di più. Si allontana deciso dall’armaiolo, e manco si gira
per un ultimo sguardo ai due scheletri pensili d’acciaio. Non v’è nulla di più difficile, quanto voler
apparire ciò che non si è. Accelera il passo e si allontana in fretta dall’artigiano che gesticola e lo
chiama da lontano. Rientrato, si guarda nuovamente allo specchio.
“Non sono poi tanto stupido” si dice, “so essere anche astuto!”
Riesce infatti a trasformare la rabbia in cattiveria, anche se per agire astutamente dovrebbe
calmarsi, diventare volenteroso e mite. Un uomo più buono, insomma, non un buonuomo, meglio,
un uomo abile, coraggioso spavaldo e anche prepotente. Qualche secolo più avanti avrebbe
potuto essere un bravo, ma non può saperlo. In fin dei conti, con tutti i suoi difetti, il Moro è un
ottimo rivale.
“Per avere qualche soddisfazione” si dice senza staccarsi dallo specchio, “devo avere un po’
più di buon senso, prendere delle decisioni equilibrate, anche se la soluzione non è imposta da
evidenze logiche. Mi giova guardarmi allo specchio, mi studio, ritrovo le mie vere sembianze!”
Anche i sogni poco alla volta cambiano, non si domanda più che cosa significhino, li vive come
sono.
“Ho sognato stanotte che stavo con Cleopatra, ero molto felice. Mi sentivo così bene che ho
persino fatto amicizia con Cesare”, racconta una mattina a Cecilia.
“Non ti confondi? Sei proprio sicuro che fosse Cleopatra e non Dalila?”
“Mi fai sorgere un dubbio... No, no, ero invece con Eva e c’era anche Adamo che rosicchiava
una mela col bruco!”
Cecilia ride di gusto, poi recita alcuni versi in latino dalle Metamorfosi dove si parla di Ulisse
che non si lascia ingannare da Circe e le fa liberare i compagni. Tutte metafore che lasciano
capire ad entrambi che non ci sono più segreti. E’ come se tra due stanze si fosse tolta la porta.
Non c’è più il buco della serratura e quindi manca l’occasione che invita a spiare. D’altro canto,
non è una novità, ciò che avviene tra le nobili coppie, sia nel Castello Sforzesco come in tutte
le altre residenze blasonate, si propala immediatamente, quasi fosse un miracolo divino. Da
quel giorno inizia un nuovo rapporto tra Bergamino e Cecilia, e si consolida pure l’amicizia tra la
coppia e il Moro, un’ambiguità di un legame che unisce tre persone, un rapporto vitale che resiste
nonostante l’infedeltà riconosciuta, l’eccitazione e l’esaltazione di un tempo, imprigionate nella
memoria.“Sta nascendo un qualcosa di inaspettato, molto macchinoso” spiega un giorno Bergamino
ad Alfonso un vecchio amico. “Aggiungerei più pericoloso di un ménage à trois, vale a dire un
ménage à quatre.”
“Che cosa mi stai raccontando?”
“Ascolta, non so se segui la complicata storia tra il Moro e Cecilia Gallerani. Il duca si prende
la quindicenne amante quando è già sua promessa sposa una delle figlie del duca d’Este,
Isabella o Beatrice. Stregato dalla bellissima minorenne, la porta sempre con sé ovunque vada,
e poi ordina al suo artista di corte di farle un ritratto. Così Leonardo da Vinci dipinge Cecilia a
Milano e termina il quadro nel 1490. La dama con l’ermellino appare subito di fattura eccelsa.”
“Sì, di questo sono al corrente.”
“Saprai allora che il Duca mi ha spinto a sposare la sua amante, ma forse non sei al corrente
che, dopo il suo matrimonio con Beatrice, Cecilia gli dà alla luce un figlio, Cesare, un motivo in più
per allontanarla dalla corte. In compenso le attribuisce il titolo di contessa di Saronno e le offre
il palazzo di via Broletto a Milano. Dopo il nostro matrimonio, io e Cecilia ci trasferiamo qui dove
sei venuto a trovarmi, a Villa Medici del Vascello in San Giovanni in Croce...”
“... molto vicina a Cremona.”
“Come vedi è una straordinaria dimora, più che una villa un fortilizio medievale, ricco di sale e
di camere, nonché di un loggiato che si apre verso i giardini che hai attraversato con la carrozza.
Un luogo ideale, caro Alfonso, un viaggio nella bellezza, tra una vegetazione lussureggiante
con persino un suggestivo lago. Una dimora che mia moglie trasforma in una sede culturale
per le menti più brillanti, ma anche una cornice che mi racchiude, ultracinquantenne, in un
quadro assurdo e impensabile con una donna così giovane. Questo almeno nei primi tempi, poi
qualcosa muta. La mia passione per Cecilia a poco a poco si affloscia. Esce spesso, se ne va
con la carrozza, non mi dice dove, né che fa, cominciamo a litigare, entro in depressione, poi mi
dedico alla scrittura che mi permette di sfogarmi e di stare meglio. Il primo risultato lo ottengo
con Cecilia, i nostri scontri verbali diminuiscono fino a scherzarci sopra. Ma non è tutto. Cecilia
mi dice di essersi incontrata con il duca più volte...”
“Ludovico! Ma che fantasie mi stai contando?!”
“Alfonso, siamo amici dall’infanzia, non ci siamo mai ingannati, siamo più di due fratelli, vuoi
che proprio ora, entrambi calvi, ti racconti delle frottole? Ascolta, devi sapere, non vorrei essere
frainteso. Non è che io provi antipatia per il Duca, se mai avversione, non odio. Anzi, in molte
cose l’ammiro. Cecilia mi confessa che la prima volta che l’incontra, a Cremona, nella casa di una
vecchia amica del duca, la passione del Moro non è da innamorato, l’aggredisce, un autentico
stupro. Ad acque chete, si scusa e le dice che Beatrice rifiuta ogni approccio, a corte tutti lo
sanno. Ogni volta che le si avvicina, lei si sente a disagio, non sta mai ferma, si mette perfino a
ridere. Gli spiega che non è ancora donna e quindi non si sente pronta a procreare. Se rimanesse
incinta, il figlio, sempre che nasca, sarebbe storpio o insano. Con infinita certosina pazienza
cerca di stimolarla, la coccola, la tiene in braccio notti intere, la tocca e l’accarezza, senza alcun
successo. Visto che proprio non ne vuole sapere e preferisce fare la ragazzina che ama il ballo,
il vestirsi con abiti costosi e diversi ogni giorno, il Moro ottiene da lei il permesso di sfogarsi
altrove...”
“Se quello che mi stai raccontando lo venissi a sapere da un altro, non potrei crederci!”
“Da questo momento i nostri rapporti, tra me e Cecilia, cambiano, capiamo entrambi di
essere condannati a qualcosa di più grande di noi, ai nobili capricci di una bambina e alle smanie
di un incontenibile erotomane. Sentiamo svilupparsi nelle nostre menti una mobilità curiosa
che ci consente di scoprire più di ciò che ci succede e di ciò che ci circonda. Guardandoci allo
specchio, cerchiamo le nostre sembianze, e ne scopriamo delle altre. Non si tratta di immagini
narcisistiche bensì di aspetti paralleli e quasi analoghi al modo di comportarsi della coppia
ducale, non certamente etici, ma l’ombra, meglio, l’impronta di ciò che non vorremmo essere...”
“Non ti seguo...”
“... in altre parole, di essere approfittatori della situazione creatasi. Penetrati nel loro universo,obtorto collo, incominciamo a carpirne alcuni lati rimunerativi.”
“Mutatis mutandis, i vostri rapporti potrebbero cambiare, e in tal caso otterreste molti
vantaggi, capisco, ma in che modo?”
“Potrebbe diventare un gioco. Come il narratore che si sdoppia in un personaggio e gli fa dire
espressioni dissociate, ai limiti della pazzia, come se non uscissero dalla sua mente ma da una
controfigura.”
“Allora sono vere le chiacchiere in giro. Ti sei dato alla scrittura, non è così?”
“Scrivere per me è solo medicina, scarica la mente, mi calma, ma non dimentico certo
l’esercito ducale di cui sono l’anziano comandante, anche se tutto ciò non c’entra con quanto
cercavo di spiegarti. La metafora dello scrittore serve a renderti più chiara l’idea che mi è venuta.
Se Cecilia ed io ci trasformassimo in controfigure e proponessimo al Moro il gioco delle due
camere con la porta aperta, le menage a quatre, che ne diresti?”