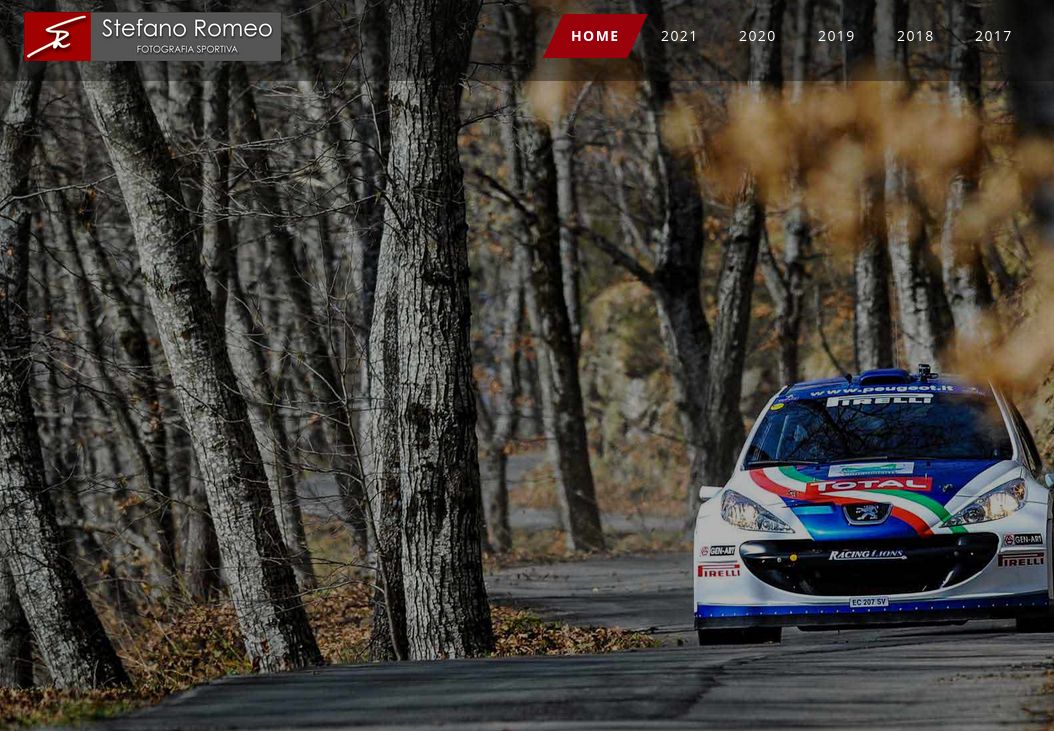Chi cerca la verità, non può essere che lo scienziato, chi invece vuole cimentarsi con l’immaginazione, sicuramente è lo scrittore. Giacomo Trotti ripensa a ciò che il Duca gli ha ordinato e si agita; non essendo né l’uno né l’altro, vorrebbe trovare una via di mezzo per accontentare il suo signore, una stanza che soddisfi la prossimità alla sua camera coniugale, senza però esagerare e, nel contempo, arredata con una fantasia che superi la normale conoscenza. Per intenderci, una stanza ideale, vicina ma non troppo, e provvista di quel tanto di magia che non la renda schiava di un modello. “Da quel che ne so” si domanda il Trotti, “ogni cosa scientifica scaturisce o no da una audace immaginazione? Gli architetti dell’antico Egitto non erano degli ottimi artisti se hanno costruito le Piramidi?”
All’improvviso qualcosa di imprevedibile. Un presagio? Un’illusione? Un pensiero inaspettato prende consistenza nella sua mente; la soluzione da lui prospettata al Moro esiste già nel palazzo, come mai non vi ha pensato? Quella stanza c’è e, se ben ricorda, vicino alla camera degli sposi. Decide di farvi un sopralluogo e, nell’ora di pranzo quando tutti sono impegnati, sale al piano notte, e scopre che una seconda porta fa coppia con quella dei duchi. Forse il Moro non intendeva una contiguità così stretta, addirittura eccessiva, pur con la benevolenza di Beatrice d’Este. Due porte identiche, gemelle. Il Trotti è un sottile osservatore, ma non le ha mai notate in altre occasioni. Forse perché sta cercando ansiosamente qualcosa, ora la vede. Non è un metafisico o un idealista ma un uomo pratico con i piedi per terra, apre lentamente la porta ed entra. Nota subito un grande letto matrimoniale in massello di noce munito di baldacchino su quattro colonne tortili ad angolo e, sulla parete confinante con la stanza del duca, scopre una porticina seminascosta da un tendaggio. Da bravo ambasciatore, è preparato ad essere scettico di fronte a certe situazioni, ma qui non può vedere altro che la vera realtà e approdare alla verità assoluta ed eterna che il suo signore è un imperdonabile erotomane. Non può dire che lo è, perché lo vede e lo tocca, ma perché quel passaggio glielo fa dedurre in tutta la sua intima razionalità. Il Trotti non è un sofista, antesignano dello scettico, non può constatare con mano e sostenere che il Moro è o non è un satiro; tuttavia quel passaggio conferma ciò che tutti sanno e il duca stesso lo ammette. Come non bastasse, si è preso poi gioco di lui, dicendogli di cercare una stanza che sa di aver già usato e che è lì bella e pronta. Nel Rinascimento anche a Milano non mancano meretrici e bordelli, ma soltanto quelle di alto bordo, le cortigiane, hanno accesso alla corte sforzesca. Non mancano belle gentildonne, ma il Trotti sa per certo che il Moro, prima di conoscere Cecilia, preferiva gli incontri al di fuori del castello, con donne non nobili da cui aveva avuto ben tre figli naturali. Al sottile osservatore che sta nel Trotti non sfugge manco l’equazione tra il dentro e il fuori. Se i tre pargoletti non li ha fatti in quella stanza, Cesare sì, perché è nato nel palazzo. Il piccolo passaggio serviva quindi al duca per andare da Cecilia e, viceversa, permetteva all’amante di passare dal suo letto con le colonne a torciglione in un altro, ben più importante, ricoperto da un baldacchino rotondo che pende dal soffitto. Come mai non glielo ha detto? Che cosa aveva in mente? Se stava cercando qualcosa, o per altri motivi, sta di fatto che per scoprirlo il Trotti deve affrontarlo. Scende lentamente la scalinata fermandosi su ogni gradino a rimuginare. Giunto nei pressi della vasta sala dove la nobiltà consuma a tavola i manicaretti della cucina rinascimentale, s’arresta e ascolta il rimbombo dei sollazzi e delle festose voci, e pensa che quel chiacchierio gli è propizio. Entra nella sala e si avvicina al Moro. Gli pone una mano sulla spalla e, quando il duca si volta, gli fa l’occhiolino, sorride e muove la testa in segno d’intesa. Il duca gli risponde, guarda in alto, e muove l’indice girandolo, come a dire: “Ho capito che l’avete trovata, poi ne parliamo.” A Villa Medici del Vascello, Bergamino e Cecilia discutono da alcune ore.“Cecilia, né tu né tantomeno io, abbiamo una visione profondamente etica o religiosa dell’esistenza; l’Alighieri, se risuscitasse, chissà dove ci sistemerebbe. Da quanto ci succede ed è successo, la nostra immagine non è altro che la brutta copia di ciò che osserviamo intorno. Maestro indiscusso è il Moro, uomo affascinante, colto e saggio ma eternamente spinto da una libido inarrestabile verso gli oggetti che appartengono agli altri. Ammetti, senza di lui non saremmo quelli che siamo. Tutti ci teniamo a diventare qualcuno, non vogliamo vivere dove nulla si può fare né dire. Ti dirò, i suoi tratti negativi non si possono ignorare, altrimenti il nostro duca apparirebbe privo di difetti e pertanto inumano.” “Come pensi di comportarti?” “Le decisioni del duca riguardo a noi mi obbligano a trascurare la moderazione. Ti dirò, non ho intenzione di evitare gli eccessi nel vino, nella parola, nel sesso, nella curiosità morbosa e persino nella riservatezza se non mi permettono di chiedere qualcosa!” “Che cosa vorresti chiedergli che non ti potrebbe concedere?” “Prima di rispondere alla tua domanda, voglio dirti che non sono geloso del tuo ritorno forzato di amante del duca. Però, proprio adesso che abbiamo trovato un accordo basato su reciproche concessioni, ti confesso che tutta questa faccenda non mi va giù, a meno che...” “A meno che?” “... il Moro accetti di estendere l’invito a palazzo anche a me! Sarebbe salvata la nostra e soprattutto la mia onorabilità. Una coppia al castello attirerebbe meno l’attenzione, la mia immagine di marito cornificato per ubbidienza si salverebbe, almeno in parte. Dormiremmo nel medesimo letto, non ti pare?” Cecilia non è del tutto convinta del ragionamento di Bergamino. Come moglie gli appartiene, ma non le va di recitare il ruolo di preda ambita, con un marito simile ad un Beagle che insegue la lepre, e un Mastino, sempre più eccitato, che gliela sottrae lasciandolo a digiuno. Una vita del genere non l’accetta, non vuole un amore fatto di brevi occasionali istanti violenti, già successi a Cremona. Si sentirebbe spregiata, non è una cortigiana, e non le va nemmeno di interpretare il ruolo della lepre. In attesa degli eventi Bergamino se ne sta a Villa Medici del Vascello seduto alla sua scrivania e cerca di scrivere. Il tempo è bello, ma non scende neanche in giardino e se esce è solo per passeggiate brevissime. Tira le tende, crea una penombra, scrive poche righe, poi straccia il foglio e butta i frammenti nel cestino che lentamente si riempie. I suoi pensieri sviano, si allargano sempre più torpidi, diventa malinconico. Rimugina, le palme delle mani accostate alle tempie, i gomiti fissi sul tavolo e lo sguardo perso nel vuoto. Non c’è nulla di più difficile che raffigurare una persona che pensa. E’ uno stato impietoso finché l’idea tanto attesa non si presenta. La sua fede crolla, l’insicurezza trionfa. Eppure il concetto della coppia che sembrava una cosa sola con la “ragione”, con le leggi logiche del pensiero è scomparsa, come se una allucinazione, una alienazione mentale, l’avessero sostituita. La voce di Cecilia alle sue spalle lo distoglie dalla mentalità crepuscolare di un poveraccio incapace di distinguere l’è dal non è. “Ludovico, scusa se ti disturbo, ho ripensato a ciò che mi hai detto. All’inizio ero titubante, poi ho pensato che si poteva tentare, però non devi essere tu a parlarne, con il Moro me la vedo io. Gli chiederò anche di portare con noi Cesare, suo figlio.” Bergamino si gira lentamente, guarda stupito sua moglie ritta in piedi, le mani sui fianchi che sorride. Si sente un grasso vermicello contemplato da una giovane gallina affamata. Cecilia, dal latino Caeculus “cieco”, patrona dei musicisti... Che melodia soave le sue parole, altro che cieca, vede fin troppo bene. E’ l’unica che può trattare col Moro. Di fronte all’amante il duca è un mastino che sente l’odore della padrona e le appoggia eccitato il muso in grembo.